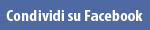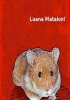[ Anno 25° - Giovedì, 10 Aprile 2025 - 4:50 ]
Psicoanalisi Oggi
L'attualità della psicoanalisi
A cura di Rosa Elena Manzetti con la collaborazione di Mary Nicotra
Psicoanalisi Oggi
07 Settembre 2011
Cosa vela l'amore?
Lo psicoanalista ha a che fare, nella sua esperienza, con i lati dell'amore che non sono proprio quelli dell'amore nella sua versione più amabile. Perchè le commedie hollywoodiane riscuotono di solito tanto successo?
Si può pensare che sia perché esse mostrano, in modo umoristico, qualcosa che appartiene al reale della vita amorosa di un buon numero di soggetti: vale a dire, le loro vicissitudini in relazione all’amore e al desiderio. Molte di queste commedie mostrano, appunto, i cammini tortuosi che i protagonisti sono costretti a percorrere, loro malgrado, per poter accedere all’oggetto del proprio desiderio. A questo punto, quando esso sembra essere stato raggiunto e tutto lascia supporre che la questione potrebbe finire lì, incominciano altri problemi, perché lui, lei, o entrambi, si confrontano con un fatto che crea loro non poche pene: amore e desiderio non è detto che coincidano. Non sempre si ama ciò che si desidera e ciò che si desidera, non lo si trova sempre nella persona che si ama. E da qui partono ancora ulteriori vicissitudini.
Nei film, dopo che la sceneggiatura porta fino al suo apice più elevato lo scarto tra amore e desiderio, ad un tratto, come per magia, le cose si mettono a posto e ciò che ci viene mostrato è che i due partner possono, finalmente, consumare la loro felice unione.
Sembra, dunque, che per l’immaginario collettivo, fare uno sia la meta dell’amore. Ma che amore è questo amore che pretende che i due facciano tutt’uno, l’uno con l’altra o l’uno con l’altro?
Lo si potrebbe chiamare “l’amore sferico”. Freud definiva Eros il principio che mira a “complicare la vita allo scopo di conservarla, aggregando in unità sempre più vaste le particelle disperse della sostanza vivente” (Al di là del principio di piacere). Troviamo in questo riferimento al dio greco l’evocazione del mito dell’unione amorosa a cui Aristofane ha dato il suo nome nel Convito platonico. Secondo questo mito, all’origine l’essere era sferico e colmo, al punto di voler fare a meno degli dei e di provocarli. La sanzione di Zeus fu di tagliarlo in due e a partire da quel momento ciascuna metà di essere umano pensa soltanto a ritrovare la sua metà complementare.
Questo mito è molto vicino all’intuizione più comune rispetto all’amore: per essere felice bisogna che mi sia dato di incontrare la mia altra metà sferica.
Il mito rende conto di due punti fondamentali della realtà dell’amore.
Da una parte, esso segnala, giustamente, che chi è colmo, non va alla ricerca di nulla. Chi è saturo, rimane lì, fermo in quella posizione, senza muoversi verso qualcuno, senza domandare, né desiderare. Soltanto a partire da una mancanza, come illustra il mito, scaturisce nell’essere umano il desiderio di andare alla ricerca di qualcuno.
In secondo luogo, il mito riprende nel proprio racconto quale sarebbe l’idea che si trova a monte di quel rivolgersi, di quel mettersi in moto ed è la convinzione, presente in ognuno di noi, che fa sì che io creda fermamente che troverò, di sicuro, poiché esiste da qualche parte, colui o colei che potrebbe colmare le mie mancanze e che a quel punto ogni mio problema (almeno quelli della vita amorosa) scomparirebbe.
Questo versante, che in psicoanalisi chiamiamo immaginario, dell’amore, esiste. In modi ed in misure diversi ogni amore ha il suo lato illusorio, immaginario. Quello che - e a volte lo si può cogliere, o quanto meno intuire anche senza aver iniziato un’analisi - in fondo ha principalmente una funzione di velo, di copertura. Funzione che è essenziale, molto importante. Freud, ma soprattutto Lacan, da un certo momento in poi del suo insegnamento, ci hanno insegnato che i veli, i sembianti, svolgono, per ciascuno, una funzione fondamentale. Certamente, come in ogni aspetto della vita, è opportuno che questa funzione sia in qualche modo calibrata, che la sua presenza sia in funzione, ma in modo tale che il soggetto vi sia avvertito.
Cos’è che l’amore vela?
Potremmo dire che le teorie psicoanalitiche che Freud ha costruito, in concomitanza con l’esperienza che man mano faceva nella sua pratica clinica, siano una teoria sull’amore. Si potrebbe leggere quasi tutto ciò che Freud ha scritto ed elaborato a livello teorico come se si trattasse di un compendio sull’amore, di una concezione teorica sull’amore: l’Edipo, la castrazione, il narcisismo, la sessualità, la teoria della libido, l’inconscio, il transfert. In questo elenco ci sono quasi tutti i principali concetti e costruzioni teoriche su cui si fonda la psicoanalisi. Quasi, però, ne manca uno, che è quello di pulsione.
Il concetto di pulsione, forgiato da Freud, è un concetto fondamentale della psicoanalisi. A differenza degli animali, governati dall’istinto, gli esseri umani, in quanto esseri abitati dal linguaggio, sono governati dalla pulsione. L’oggetto della pulsione è, tra i suoi elementi, quello più variabile. Ciò vuol dire che nell’essere umano, l’oggetto nel quale la pulsione troverà la sua soddisfazione, non è geneticamente determinato. La “scelta”, se così si può dire, dell’oggetto della soddisfazione pulsionale, è una scelta che si gioca molto presto nella vita di ciascuno e che avviene per accidente. Infatti, non si tratta di una scelta, oppure, non sin da subito; piuttosto l’oggetto privilegiato per il soddisfacimento pulsionale, in virtù di una certa combinatoria che si sarà venuta a configurare per il soggetto infantile, rimarrà a posteriori fissato nella sua funzione di soddisfare la pulsione e da lì in poi, a livello inconscio, per il soggetto si metterà in atto una ripetizione di quella modalità specifica di soddisfazione, al di là della sua intenzione e in modo del tutto estraneo alla sua coscienza.
Ci sono certi oggetti che si prestano meglio ad essere oggetti di soddisfazione pulsionale, a causa della funzione che hanno sin dall’inizio della vita del soggetto nel rapporto con l’Altro che in principio si prende cura di lui e più avanti negli scambi del soggetto con l’Altro. Freud ne ha individuato tre: l’oggetto orale, l’oggetto anale e l’oggetto fallico. Lacan ne ha aggiunto altri due: l’oggetto sguardo e l’oggetto voce.
L’oggetto che soddisfa la pulsione, però, non è l’oggetto che soddisfa il desiderio. Mentre la pulsione si soddisfa sempre, vale a dire, giunge prima o poi alla sua meta che è appunto la soddisfazione, il desiderio resta sempre insoddisfatto. Questa è la definizione del desiderio: il desiderio come desiderio insoddisfatto.
Il mito di Aristofane ci aiuta per comprendere la logica del desiderio. Il soggetto umano parte, miticamente parlando, da una condizione di completezza, di assenza di mancanza (anche se non è poi proprio così nella realtà, almeno non lo è totalmente e sempre). Il mito ci dice che quando ci si trova in una tale condizione, di non mancanza, non si può che essere non desiderante. In un secondo momento, avviene un’operazione di taglio. Nel mito è Zeus, il dio di tutti gli dei, il padre dell’ Olimpo, che compie questo taglio che dà la nascita al soggetto in quanto soggetto desiderante.
Anche per la psicoanalisi, la nascita del soggetto come soggetto del desiderio, avviene a partire da un taglio. Un taglio simbolico, però. È ciò che in psicoanalisi chiamiamo castrazione. La castrazione non è opera di qualcuno nella realtà.
Essa è il pegno che il soggetto umano paga per il suo ingresso nel linguaggio, ingresso che gli apre la via al desiderio, in detrimento di una mitica situazione di illusoria beatitudine e di assoluta libertà. Il linguaggio, struttura che ci determina, produce contemporaneamente un secondo effetto sull’essere vivente: la sua lama, cadendo sul soggetto, causa la morte della cosa in quanto tale, e lascia un resto. Un resto di godimento localizzato in uno di quegli oggetti privilegiati.
Questo godimento è singolare e specifico a ciascuno e non è condivisibile con nessuno, costituendo il punto causale attorno al quale si organizzano e prendono forma tutte le successive elaborazioni del soggetto.
Si va dall’analista quando l’equilibrio del nostro mondo, equilibrio che era mantenuto in piede dall’amore in alcune delle sue forme, viene squarciato dall’irruzione di un reale che riguarda sempre qualcosa di quel godimento. Il soggetto non lo riconosce, né come proprio, né come familiare, ma patisce tutta l’insopportabilità di quel reale perturbante in cui ad un tratto il suo specifico modo di godere si manifesta.
Relazioni d’amore tormentose ed impossibili, separazioni che diventano eterne, difficoltà per mantenere una relazione amorosa, difficoltà nelle relazioni con i figli o i genitori, ecc., sono l’effetto dell’ascesa in primo piano della modalità individualista di godimento di ciascun partner, modalità che non agevola il legame, ma che, quando si presenta in modo dirompente, piuttosto tende al suo disfacimento o degrado.
Ben presto scopre Freud che il perno attorno al quale la relazione analitica gira è il transfert – e la sua controparte sono l’interpretazione e l’atto dell’analista.
L’amore di transfert, quel moto pulsionale che si dirige dall’analizzante all’analista, motore e ostacolo della cura, come dice Freud, non è, in quanto amore, il suo cardine reale.
L’amore di transfert, inteso come “amore autentico”, come lo scrive Freud nello scritto Nuove osservazioni sull’amore di transfert, non si rivolge alla persona dell’analista; guai se l’analista lo prende in questo modo!
L’amore che l’analizzante dà all’analista è come una copertura, una finzione nella cui trappola l’analista non dovrà cadere, pena di impedire l’avanzamento dell’analisi.
L’amore autentico non è rivolto a qualcuno, ma è desiderio di sapere che si dirige ad un luogo. Un luogo che l’analista occupa non in quanto soggetto desiderante (che lui è, ma altrove).
Lacan si riferisce a ciò come “desiderio dello psicoanalista”, che non è un desiderio di qualcosa o di qualcuno, ma è una funzione.
Il desiderio dello psicoanalista è un luogo che occorre che sia svuotato da ogni desiderio; è un desiderio svuotato di un posto di desiderio.
Nel Seminario sul Transfert, Lacan dice che si tratta “del posto che egli – l’analista – deve offrire vuoto al desiderio del analizzante, affinché questo si realizzi come desiderio dell’Altro”.
Il desiderio dello psicoanalista è desiderio che del soggetto inconscio si produca.
Maria Laura Tkach
Leggi gli altri Ritratti di donne ->

Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano.
Formazione di laureati in medicina e di laureati in psicologia che scelgano di proseguire la loro formazione in psicoterapia, secondo la psicoanalisi freudiana orientata dall'apporto teorico-clinico datole da Jacques Lacan. Istituto riconosciuto dal MIUR con DM 25.11.2011.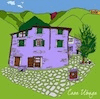
Casa Ubaga, un luogo nell'entroterra ligure dove circolano saperi in condivisione
LA CITTADELLA di Saluggia, residenza sanitaria assistenziale per persone giovani e adulte con Sla, Sclerosi Multipla, malattie neurovegetative e anziani

HOMELESS CHILD DonneInViaggio sostiene il progetto di Honduras per i bambini di strada Puoi collaborare anche tu
DIV Network
 Div-BestStayInItaly pernottare in Italia.
Bed and Breakfast Abruzzo
last minute
Offerte Speciali
Bed Breakfast Calabria
Vacanze hotel emilia romagna
e in tutta italia.
Div-BestStayInItaly pernottare in Italia.
Bed and Breakfast Abruzzo
last minute
Offerte Speciali
Bed Breakfast Calabria
Vacanze hotel emilia romagna
e in tutta italia.
 Bed and Breakfast Liguria
last minute
Bed Breakfast Molise
Vacanze bed breakfast marche
Bed and Breakfast Liguria
last minute
Bed Breakfast Molise
Vacanze bed breakfast marche
 Div-BestStayinitaly
Bed and Breakfast Firenze
bed breakfast offerte
Bed Breakfast Roma
Vacanze Bed Breakfast Torino
Vacanze Bed Breakfast Torino
Casa vacanze Liguria
Appartmenti, B&B Torino
Vacanze mare Liguria
generi.org
Casa Ubaga
Psicologa clinica, Psicoterapeuta a Torino
Div-BestStayinitaly
Bed and Breakfast Firenze
bed breakfast offerte
Bed Breakfast Roma
Vacanze Bed Breakfast Torino
Vacanze Bed Breakfast Torino
Casa vacanze Liguria
Appartmenti, B&B Torino
Vacanze mare Liguria
generi.org
Casa Ubaga
Psicologa clinica, Psicoterapeuta a Torino
Vuoi pubblicare articoli, news, comunicati su DonneInViaggio? Registrati
Se sei già registrata/o vai al Login

Iscriviti alla newsletter per essere informata/o sugli aggiornamenti della rivista
Leggi altre news ed eventi ->
Leggi altre Libri ->
Info Rivista
Rivista a cura
dell'Associazione DonneInviaggio
Direttrice Editoriale: Mary Nicotra
Direttrice Responsabile: Elena Vaccarino
Registrazione Tribunale di Torino N° 5466 del 21.12.2000
Tutti i diritti riservati. E' proibita ogni riproduzione anche parziale di testi e immagini senza autorizzazione scritta.
Sito realizzato da: Maurizio Scarpino